Riporto qui di seguito un prezioso reportage su un recente viaggio in Eritrea a cui ho partecipato. L’autore, Valerio Crugnola, è stato un acuto e attento osservatore di una società e di un Paese legati alla storia dimenticata del colonialismo italiano e oggi afflitti da una dittatura, una povertà e un conflitto bellico devastanti. A completamento dell’articolo un set di foto.
L’Eritrea è un paese malato. La sua malattia è una dittatura militare a sfondo ideologico. Le dittature ideologiche si distinguono dalle dittature pure, di stampo hobbesiano, proprio perché cercano la loro legittimazione in un’ideologia vissuta come religione civile che si impone sulla comunità e la permea in ogni manifestazione della vita.
L’ideologia che ispira la brutale dittatura di Afewerki, e degli altri personaggi che lo circondano, è un impasto di nazionalismo, a sfondo vagamente autarchico, e di marxismo-leninismo (dirigismo statale; controllo totale e pervasivo sulla popolazione, sui media, sui movimenti delle persone, sui flussi economici, finanziari e valutari, sul turismo, inteso come qualcosa di potenzialmente minaccioso, e sulle religioni e le loro nervature istituzionali; inamovibilità del gruppo dirigente; reiterazione del culto del mito fondativo della dittatura – l’indipendenza nazionale, l’eroica lotta di liberazione – come forma perenne, carismatica ed esclusiva di legittimazione del potere, in assenza di libere elezioni, la sola forma possibile di legittimazione democratica di un governo; monopolio totale sull’informazione e sulla produzione intellettuale e culturale; egualitarismo a sfondo rurale, con l’intento primario di assicurare la sopravvivenza nelle campagne; chiusura totale delle comunicazioni e delle interdipendenze della popolazione civile con l’esterno).
Ciò comporta la radicale, e pressoché integrale, militarizzazione della vita. L’esercito non si limita a controllare la società; ne divora le risorse, ne inquadra e governa ogni struttura e ogni logica; e non può fare a meno dello stato di guerra, in particolare dello stato di guerra contro il Nemico-per-eccellenza, il Nemico-in-sé-e-per-sé, archetipo platonico di ogni nemico, l’Etiopia, e contro i suoi alleati, a cominciare dagli Stati Uniti, amici e sostenitori (è un dato di fatto) della dittatura di Melles (decisamente più blanda, perché deve rendersi compatibile con l’economia di mercato e con la globalizzazione economica).
La guerra è la legittimazione del regime, e non può cessare, pena la deligittamazione del regime, e dunque pena il rischio di una sua crisi.
Ma non c’è solo questo, La dittatura di Afewerki blocca e inibisce ogni possibile sviluppo del paese. Non lo tutela contro la minaccia della fame, contro il degrado ambientale, contro le malattie, l’analfabetismo e la scadente qualità dell’istruzione, contro la povertà, e neppure (aspetto importante nella prospettiva di un turista straniero, e in particolare italiano) contro il degrado del patrimonio paesaggistico, artistico e architettonico del paese.
L’assenza di futuro, l’assenza di speranza, l’assenza di aspettative che non concernano il puro sopravvivere, il disperato agitarsi a vuoto per riprodurre com’è la nuda vita, sono la condizione esistenziale di ogni eritreo che non sia cooptato nella ristretta sfera del potere e dei suoi privilegi. Chiunque visiti l’Eritrea, con occhio indagatore e libero da pregiudizi favorevoli di sapore terzomondistico, può percepire questa condizione.
La logica tirannica in base alla quale chiunque può recare il minimo disturbo al manovratore va bandito, cacciato o perseguitato, frena persino quella cooperazione internazionale potenzialmente amica, che ha appoggiato in profondità e con piena dedizione, la lotta di liberazione. E’ sintomatica la cacciata di Mani Tese, l’ong italiana che più si è spesa per la causa dell’indipendenza eritrea, ma che non ha potuto nascondere il suo dissenso nei confronti dell’involuzione dispotica che la lotta armata ha prodotto e delle scelte belliciste, militariste e autarchiche che ne sono conseguite. Va da sé che Afewerki e soci preferiscano i rapporti verticali, ben più fruttuosi per i loro destini e per le loro fortune economiche personali, con le istituzioni dei governi a loro amici, come quello di Berlusconi e perfino con il governo regionale lombardo di Formigoni: governi amici di governanti, non governi amici di popoli (tutti sappiamo cosa combinano Silvio, Maroni e soci nei confronti dei profughi eritrei che fuggono disperati dal loro paese a fronte di sacrifici enormi attraverso le frontiere con il Sudan, per poi finire annegati nel canale di Sicilia o rispediti in Libia a marcire senza aver commesso alcun reato nelle galere di Gheddafi, l’ultimo accolto da Berlusconi nella sua brillante collezione di amici accanto a Bush, Putin ecc.). L’Eritrea, e il suo prezioso Mar Rosso in particolare, sta diventando la discarica della spazzatura ambientalmente pericolosa prodotta in Italia: la dittatura eritrea impedisce che la popolazione locale ne possa essere minimamente informata, e la anomala dittatura mediatica che opprime l’Italia rende molto difficile documentare concretamente i contenuti di questa alleanza verticale tra vertici governativi. Ma noi italiani almeno possiamo sperare nei cognomi che finiscono il -elli: in Lucarelli, nella Gabanelli, e magari in consiglieri coraggiosi come Mario Agostinelli (che sarebbe triste non vedere rieletti, ma si sa che la sinistra italiana è autolesionista fino all’inimmaginabile). Gli eritrei, al contrario, non possono sperare in nulla.
Eppure il popolo eritreo ha grandi risorse: la consuetudine con il pluralismo religioso; il retaggio di una civilizzazione aperta all’ospitalità, alla diversità; un’invidiabile (per l’Africa tutta, e non solo per l’Africa islamizzata) emancipazione femminile, frutto della lunga lotta di liberazione; l’assenza di conflitti etnici (il conflitto etnico e l’incapacità di gestirli al di fuori di una logica imperiale alla Haile Selassie, la causa remota di tutti i gravissimi mali passati e presenti dell’Etiopia, caratterizza invece pesantemente la dittatura di Melles); una vitalità e uno spirito di intraprendenza notevoli, per quanto frustrati dalla tristezza, dalla melanconia, dalle delusioni, dai dolori privati e dalla cappa di piombo che la dittatura ha portato con sé; e i suoi migranti, negli Stati Uniti piuttosto che in Italia, che non solo contribuiscono con le loro rimesse e i loro aiuti diretti orizzontali alla sopravvivenza di molte famiglie, per lo più urbane, ma che anche e soprattutto sono i più consapevoli della realtà di fatto in cui versa tragicamente il loro paese, nonché gli unici che possano al momento fare qualcosa. Ma per ora queste risorse giacciono a terra inerti, anche se affiorano timidamente nei pochi, rarefatti contatti autentici (e autenticamente dialogici) che uno straniero può sperare di instaurare. Per ora, soprattutto, la lotta di indipendenza ha soffocato, con la sua ideologia nazionalista e con la sua ricaduta militarista, le spinte di emancipazione e di partecipazione diretta che sono in qualche modo contenute in ogni lotta di liberazione. Nel dna del popolo eritreo è inscritta una potenziale sensibilità verso la democrazia, il pluralismo e i diritti umani e civili che per ora tace, vuoi perché soffocata pesantemente dalla tirannide, vuoi perché velata tuttora dall’ideologia nazionalista (il nazionalismo è stato di tutti i cancri del ‘900 quello peggiore, anche perché trasversale e fondante di tutte le altre ideologie, si vedano Stalin e Hitler, ma anche Milosevic e Tudjman, ma anche Begin e Arafat, ma anche, nel loro piccolo, Melles e Afewerki…), vuoi perché infine priva di quei contesti educativi ed esperienziali che questa sensibilità potenziale possono trasformare in una pratica vissuta e condivisa.
La pace, la dismissione della logica bellicistica, la fine della militarizzazione della società, la drastica riduzione delle spese militari, la restituzione alla società delle risorse – braccia, menti, benzina, cibo, acqua, denaro… – che attualmente l’esercito eritreo divora, sono la condizione prima per il passaggio dell’Eritrea a un sistema di libertà, di democrazia, di pluralismo, di diritti umani e civili.
Tocca probabilmente agli eritrei all’estero, agli etiopi all’estero, e a uomini e donne stranieri di buona volontà, avviare un’azione di sensibilizzazione sull’attuale tragica situazione dell’Eritrea. Prima o poi questa azione arriverà a destabilizzare la dittatura e a sfondare il muro che i tiranni hanno elevato, per avere un’eco sulla popolazione civile locale. Il canale diretto tra migranti e autoctoni può in questo senso fare molto. Come possono fare molto gli etiopi all’estero, per far maturare un clima orizzontale di incontro tra etiopi ed eritrei, per avviare una riflessione sul loro tragico passato comune che spazzi via ogni rimpianto per personaggi disgustosi, feudali e dispotici come Haile Selassie, il cui rifiuto di una federazione con l’Eritrea in nome di una grottesca filosofia imperiale è all’origine del dramma eritreo, ogni spirito militarista, ogni odio pseudonazionalista, senza pretese di supremazia (il pericolo strisciante nella mentalità etiopica), e avvi un confronto sul futuro immediato dei due paesi e dei loro molti popoli, un futuro di cooperazione e integrazione reciproca, di convergenza economica, di interessi comuni, di sinergia territoriale, di incontro multietnico in nome di una cultura, una civiltà e una storia comune.
In questo gli italiani possono fare la loro parte più di altri paesi occidentali, per il legame storico che li unisce all’Eritrea. Certo anche agli italiani compete separare, in questo legame, il grano dal loglio: di qui la vergogna del fascismo, la vergogna dei gas di Graziani e in genere dei crimini di guerra e di pace della dittatura, la vergogna della sottomissione coloniale e delle battaglie coloniali, da Adua a Dogali fino a Keren; di là l’orgoglio legittimo per quanto molti italiani di buona volontà, quale ne fosse all’epoca la visione, hanno saputo fare a favore del popolo eritreo. Per limitarmi a tre esempi tratti da altrettanti miei compagni di viaggio, penso alla famiglia De Nadai, imprenditori agricoli e commerciali, del cui ruolo e del cui apprezzamento tra gli eritrei ho avuto personale e diretta testimonianza, in modo del tutto casuale; penso al padre di Ugo Sleiter, valente ingegnere civile, morto tragicamente in un campo di concentramento inglese; penso infine alla famiglia di Erminia Dell’Oro, e alla stessa Erminia, che porta nelle sue carni proprio la capacità di scindere il bene dal male nell’eredità italiana in Eritrea e un amore profondo (come anche in Paola De Nadai) per questa terra, il suo popolo e il suo destino.
La cooperazione italiana può fare molto per restituire all’Eritrea quanto dovuto per le colpe del colonialismo e del fascismo, e per restituire all’Italia il tributo di memoria di quanto di buono gli italiani come cittadini, come esponenti di un popolo e non come emissari di un regime, hanno saputo portare in Eritrea (lo stesso vale per l’Etiopia, sia pur con proporzioni diverse, dacché i mali arrecati esuberano i benefici arrecati, e forse persino per la disgraziata Somalia, che non conosco).
Indico qui tre vie non particolarmente originali, data la loro ovvietà, da percorrere in questo senso, ma che hanno anche un valore inedito, quello di destabilizzare la dittatura.
1) Il restauro urgente (e integrale) dell’architettura coloniale italiana, che vanta alcuni capolavori assoluti, tra cui spicca il celebre distributore di benzina Fiat Tagliero in Asmara, può e deve essere un compito che l’Italia può assumersi, e che può essere un buon volano sia per l’edilizia italiana che per l’edilizia eritrea (ed etiopica). In particolare sembra urgente il restauro della città di Massaua, visto come premessa per la ripresa del porto e della vita turistica della città.
2) Il rilancio delle scuole italiane; l’avvio di una cooperazione interuniversitaria in settori cruciali come l’agraria, la medicina, l’ingegneria e le scienze dell’ambiente; la promozione di istituti italiani di cultura che non siano solo delle tristi greppie per i raccomandatucoli di qualche politico di turno, di qualche notabile del ministero degli esteri o degli esponenti del neo-minculpop naziberluscoleghista; la promozione di un intelligente turismo della memoria, che unisca Eritrea ed Etiopia, contribuendo di fatto alla ripresa dei rapporti tra i due paesi.
3) Un’azione dal basso di cooperazione internazionale, supportata dal governo italiano e dalle regioni, purché ciò abbia luogo per progetti di sviluppo finalizzati, democraticamente controllati, finanziariamente trasparenti, ecologicamente e militarmente puliti, politicamente indipendenti, non rivolti a scopi affaristici alla maniera della Compagnia delle Opere, e instaurati direttamente con la società civile locale, onde promuoverne lo sviluppo e il radicamento. Etiopia ed Eritrea possono essere un terreno elettivo per la cooperazione italiana, fatte salve queste fondamente condizioni politiche.


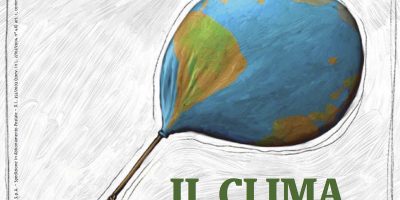
 Mario Agostinelli, sposato con due figli e cinque nipoti, è oggi presidente dell’
Mario Agostinelli, sposato con due figli e cinque nipoti, è oggi presidente dell’
Fithawit
Salve Sig.re Mario ,
Lei Scrive :
“Ma non c’è solo questo, La dittatura di Afewerki blocca e inibisce ogni possibile sviluppo del paese. Non lo tutela contro la minaccia della fame, contro il degrado ambientale, contro le malattie, l’analfabetismo e la scadente qualità dell’istruzione, contro la povertà, e neppure (aspetto importante nella prospettiva di un turista straniero, e in particolare italiano) contro il degrado del patrimonio paesaggistico, artistico e architettonico del paese.”
Non so dove si è disinformato, in Eritrea ci sono dei problemi nessuno lo nega, ma ciò che scrive è lontano dalla realtà. l’Eritrea è uno dei pochi paesi che raggiungerà gli Obbiettivi del Millennio.
La Banca Mondiale ha pubblicato un reportage che mette in rilievo i successi conseguiti dell’Eritrea.
Il Fondo Monetario Internazionale ha constatato i buoni progressi realizzati dall’Eritrea nel settembre scorso.
Dia un’occhiata al seguente Link:
http://www.youtube.com/watch?v=19yIGjH3joE&feature=channel
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09337.htm
Distinti Saluti.
Fithawit W.