1. In una fase di stagnazione e in assenza di conflitto sociale la visione del futuro è pura ripetizione del presente, i posti di comando sono appannaggio dei mediocri, l’opinione pubblica si ammanta di buon senso, la cultura perde la sua funzione critica: in sostanza il potere appiattisce quella dialettica che impedirebbe alla crisi di sortire solo effetti regressivi. Noi che esecriamo il ventennio berlusconiano, dovremmo riflettere sulla progressiva scomparsa, per colpa di una sinistra imbelle o velleitaria, della rappresentanza politica delle lotte che pure hanno attraversato questi anni. Senza traccia,come meteore destinate a scomparire per la mancanza di un riferimento organico e un progetto di trasformazione in cui inserirsi. Per questo la vicenda Fiat-Fiom, sia per l’attacco definitivo portato al cuore del lavoro, che per le implicazioni sul futuro produttivo dell’Italia e, nondimeno, per la reazione del sindacato di Landini, per il coagulo sorprendente attorno ad essa di movimenti e associazioni e il ritorno in gioco di forze intellettuali, rappresenta una occasione per fermare la deriva e smettere di sobbarcarsi il peso di sconfitte senza combattere.
Quando penso che la Lega detta l’agenda nazionale delle riforme istituzionali e che la espulsione della Costituzione dalle fabbriche torna di attualità con la benevola sospensione di giudizio del PD, temo che il futuro del Paese sia tracciato da una classe dirigente che affronta la più complessa sfida del dopoguerra con la ricetta dell’esclusione e, in emulazione di un capo di Governo che compra voti in Parlamento, dell’impunità. In fondo, la continuità di un sistema classista e la propensione all’esclusione è quanto gli studenti rinfacciano senza sconti al governo, sostenitore in tutte le sue articolazioni del “pensiero unico”. Una strategia passiva, che si riproduce da trent’anni e vorrebbe oggi riammantarsi di modernità al prezzo della demolizione del dissenso e dell’abolizione del conflitto. Una “modernità” che ha dato pessima prova nella crisi in corso e che si vorrebbe rilanciare sulla pelle dei giovani, del lavoro e delle classi popolari. Allora, non deve far specie che ad un Cavaliere (Berlusconi), che usa le cariche pubbliche per coprire i suoi affari personali e per assicurarsi impunità, venga data sponda da due Cardinali (Bagnasco e Bertone), che in cene poco evangeliche benedicono un governo agli antipodi della testimonianza cristiana. E nemmeno che un imbolsito predicatore della superiorità del Nord (Bossi) sguazzi nella “palude romana” e da lì approvi l’abbattimento della dignità del lavoro operaio nostrano a livelli da terzo mondo, così come li impone un manager (Marchionne), rappresentante di un capitalismo anonimo che scorazza spietato per il mondo. La stampa e i media nazionali sembrano attratti dagli atteggiamenti muscolari e dall’arroganza di queste classi dirigenti, anche quando non sono palesemente all’altezza dei compiti. Ne celebrano quindi i fasti sotto la luce inverosimile dell’innovazione anche quando si tratta di un ritorno deprimente a 50 anni addietro. Naturalmente i comprimari si sprecano: ministri bacchettoni, economisti promotori e difensori delle ricette più fallimentari, sindacati ormai privi di autonomia e perfino politici “di sinistra”: tutti incredibilmente loquaci e alla rincorsa, alla loro non più giovane età, di una restaurazione classista, dopo aver combattuto invano per quaranta anni per lo smantellamento delle “casematte” del ‘68. Già, perché avessi trovato un giornalista che andasse a chiedere, ad esempio, cosa pensano di Mirafiori e Pomigliano gli studenti del movimento sceso in piazza in questi giorni! Pareri certo meno scontati dei ritriti Gelmini o Giavazzi, Pansa o Ichino, Manghi o Fassino…
2. Proprio sulla scorta della mia esperienza sindacale, parto dal “picconatore”(così lo definisce compiaciuto il Corriere della Sera) Marchionne, plenipotenziario in FIAT, per smontare una tesi aberrante che lo vorrebbe in un ruolo di scomodo “riformatore”. I maggiori quotidiani nazionali sostengono che la globalizzazione implichi lo scambio inevitabile tra diritti e occupazione. Lo sosterrebbero mai nei loro paesi Steve Jobs innovatore informatico o Martin Winterkorn, presidente Volkswagen? Perché, allora, accettare da un uomo della finanza internazionale, abituato a giocare con soldi non suoi e sprovvisto di solida esperienza industriale, il luogo comune classista per cui sicurezza, condizioni di lavoro, dignità e salario non siano prerequisiti per far funzionare una linea di produzione, come possono dimostrare un’infinità di casi? Perché accettare che il declino storico del ciclo auto individuale-petrolio dia spunto solo in Italia per una regressione di tutto il mondo del lavoro, quando negli altri paesi dove si ristruttura o rilocalizza (Germania, Brasile, Serbia o Cina) si mantengono o addirittura migliorano le condizioni locali dei salariati nel settore? E che dire della giustificazione “da sinistra” per cui, per risanare l’impresa in cui lavorano, sarebbero i sindacati americani, “comproprietari” della Chrysler a pretendere in nome dell’equità il livellamento delle fabbriche italiane alle normative statunitensi, quando, per lo stesso fine, non si sono mai posti il problema di arretrare loro per primi al dislivello degli stabilimenti di Brasile e Polonia? La realtà è che per gli inossidabili sostenitori del manager italo-canadese la globalizzazione funge da copertura per una negazione di autonomia della vita e dell’organizzazione sociale anche nei luoghi e nei momenti in cui più acute si presentano le contraddizioni di questo sistema. In fondo molti hanno accostato Mirafiori e la legge Gelmini solo per esorcizzare una presa di contatto fra due realtà – lavoro e studio – che impongono di ridiscutere il futuro rivendicando contemporaneamente un potere democraticamente legittimato. La si smetta allora con la scusa della dolorosa mancanza di alternative e si ammetta che per Fabbrica Italia non si tratta di una proposta industriale, ma di un ricatto a cui si piega tutto il sistema. E che non c’e’ piano d’impresa, ma solo la volonta’ di imporre un metodo, sovvertendo radicalmente i rapporti di potere tradotti fin qui dalle leggi e dai contratti in vigore. E, ancora, si cerchi di andare a capire perché, alla luce di quanto sta accadendo, gli operai e il sindacato tedeschi hanno chiuso la porta della Opel in faccia a Marchionne. Allora ha ben ragione la FIOM a cogliere nel referendum che si terrà a Torino un ricatto inaccettabile che, se fosse legittimato come espressione di democrazia, sancirebbe davvero che la nostra Costituzione non può varcare i cancelli delle fabbriche. E domando ora: perchè non è mai stato preso in considerazione l’esito di un referendum che ho vissuto direttamente nella mia esperienza sindacale all’Alfa di Arese, quando gli operai avevano votato all’unanimità e liberamente per riconvertire lo stabilimento auto a prodotti per la mobilità sostenibile e la Fiat ha invece fatto deserto su due milioni di metri quadrati (si veda la testimonianza del video http://www.youtube.com/watch?v=B97sTMZmgcE ), dove dal 2011 sorgeranno villette e supermercati?
3. L’attacco di Marchionne alla Fiom ha quindi natura espressamente politica e si muove sul piano aziendale per cancellare il sindacato conflittuale e sul piano generale per far accettare per indiscutibile la supremazia dell’economia sulla politica. Da questo punto di vista, l’impedimento ai lavoratori di autorappresentarsi nei reparti con libere elezioni e di ricorrere al diritto individuale di sciopero, è propedeutica all’espulsione definitiva della Costituzione dalle fabbriche. Nessun patto, infatti – e tantomeno quello di democrazia sociale a cui si ispira la Carta Italiana – può essere tollerato da una ideologia eversiva che si fonda sul primato assoluto dell’impresa globale sul lavoro, a prescindere dalla storia, dalla cultura e dal contesto in cui si applica. Ma a chi tocca fare un bilancio ampio costi-benefici del ricatto cui sono sottoposti i lavoratori torinesi, chiamati a barrare una casella sulla scheda da cui dipenderà l’imposizione di nuovi rapporti di forza da estendere all’intera società nazionale? Non vorrei esagerare, ma trovo un po’ codardo il comportamento dell’”uomo dell’anno” quando prescrive che l’investimento e i diktat sulle condizioni di lavoro facciano un tutt’uno, giocando così una partita truccata, da cui vengono esclusi a priori giocatori di diritto. Infatti, la gran parte delle rappresentanze degli interessi sociali, civili, ambientali che verranno condizionati dall’esito obbligato del referendum non partecipano in alcun modo alla decisione che verrà ratificata a metà gennaio dai cassintegrati (!) di Mirafiori. E’ bene che esse si sentano comunque coinvolte, innanzitutto sostenendo la FIOM che vuole riaprire la partita e partecipando alla riuscita della giornata di sciopero e mobilitazione del 28 Gennaio. Una giornata campale, che potrà dare la misura della parzialità degli interessi che stanno dietro Marchionne. E vorrei che se ne parlasse, perché troppo poco si è discusso di come un’uscita dalla crisi attuale ancora una volta a vantaggio della voracità dei rappresentanti di un capitalismo finanziario anonimo – che “accumula ricchezza e distribuisce povertà” (Ratzinger!) – e a scapito di una collettività che dovrebbe semplicemente prostrarsi al loro servizio, metta a repentaglio, se applicata su scala mondiale, sia la sopravvivenza della convivenza civile che i limiti biofisici del pianeta. Non ci si può limitare a pretendere nuovi paradigmi per affrontare una crisi definita epocale e poi ripiegare senza confliggere apertamente ad accettare l’emergenza che ci viene propinata in casa. In questo senso, è intollerabile che non solo questo Governo, ma la maggioranza delle forze politiche, gran parte del mondo sindacale e chi orienta l’opinione pubblica, consegnino il timone delle politiche industriali e il futuro dei diritti del lavoro dipendente di un Paese di grande rilievo europeo ad un manager che ha come unica bussola il successo che il mercato decreterà alla sua avventura.
4. Allora, che fare oltre che resistere? Penso che l’arroganza e l’inadeguatezza delle nostre classi dirigenti possa mascherare un declino, ma non impedire ad una resistenza ostinata di tramutarsi in una alternativa desiderabile. Da qui traggo la certezza che non accettare il terreno dei ricatti di Pomigliano e Mirafiori – e qui occorre stare da subito con Landini “senza se e senza ma” – sia la condizione per tracciare un percorso di proposta che parta a) dai poteri oltre che dai diritti, b) dal piano strategico d’impresa mai comunicato finora, c) dai nessi tra finalità della produzione, organizzazione del lavoro e qualità sociale e ambientale che ne derivano. Tutti temi da cui Marchionne e la sua “claque” vogliono distogliere l’attenzione, costringendoci ad una battaglia difensiva e forse disperata. Ma anche temi che la CGIL, il sindacato oggi da battere per la sua natura confederale e non aziendalista, non ha mai cessato di elaborare per non subire passivamente gli effetti della globalizzazione. Fin dalla ristrutturazione del settore tessile, affrontata con buon successo negli anni ’80, la storia di questa confederazione si identifica con l’autonomia e l’esercizio di un potere contrattuale conferito dalla rappresentanza democratica delle lavoratrici e dei lavoratori, che proprio in quanto detentori di un potere e soggetti del patto costituzionale hanno il diritto di non dover scegliere o disoccupazione o precarietà. Come interpretare una “firma tecnica” a Mirafiori, dove il sindacato viene scelto dall’azienda?
Allora, se non si firma, dicono in molti? Vediamo un pò. I rapporti tra libertà-politica, libertà-civile e libertà-sociale posti alla base, questi sì, di un’ideologia che è quella della nostra Costituzione, prevedono poteri anche nei luoghi di lavoro, che vanno oltre i diritti individuali e che senza il sindacato dei lavoratori non si potrebbero esercitare. In fondo, il capitalismo di Marchionne vorrebbe abolire questo potere conquistato in anni di lotte e di prove democratiche ed escluderlo a priori e definitivamente, anche abbandonando il sistema confindustriale che lo vincola. La rinuncia a questo ruolo da parte del sindacato sarebbe una uscita di scena senza ritorno, una trasformazione della confederalità e dell’autonomia in funzioni pro-azienda, come al massimo il controllo delle assunzioni, il raffreddamento complice del conflitto, l’applicazione burocratica dell’organizzazione del lavoro non contrattata. Il controllo democratico dell’economia, che aveva trovato traduzione nelle conferenze di produzione, nella stagione della “prima parte” dei contratti e dei piani di settore e, in seguito, si dimensionava nella concertazione (di cui fa parte l’accordo del 1993 sulla rappresentanza che Romani dichiara non più proponibile), verrebbe negato nel suo snodo fondamentale a contatto diretto con le forme di produzione. Una negazione tanto più gravida di conseguenze nella fase cruciale in cui si rende necessaria la riconversione ecologica e sostenibile del settore industriale. Meglio allora tenere la FIOM fuori dalla trappola e riorganizzare da lì tutte le alleanze necessarie a riposizionare dentro i luoghi di lavoro un diritto che non si può pretendere senza potere. Un potere che allude a quale possa essere il ruolo dei lavoratori organizzati nel perseguire con successo obiettivi di cambiamento: più giustizia sociale, secondo la tradizione del movimento operaio, ma anche giustizia ambientale nell’esigere modalità e finalità di produzione in armonia con la natura.
5. E qui siamo al piano strategico della FIAT che, secondo Sacconi, è offensivo richiedere al suo AD, visto che lo si dovrebbe prendere in parola e che l’unica responsabilità sociale l’avrebbero i lavoratori che gliene chiedono conto. Ma chi meglio del sindacato è titolato ad esercitare la sua autonomia culturale e politico-sociale per contribuire all’elaborazione e alla certezza del piano d’impresa, soprattutto in una situazione dove le incognite sono tantissime – dalla cattura di Fiat da parte di Chrysler (“il morto che prende il vivo”), allo spezzatino delle produzioni del settore auto motive con la deriva del ramo industrial che non interessa Detroit, all’acquisizione e vendita di marchi (Alfa Romeo in particolare, che in questa situazione sarebbe un gran bene se fosse acquisito e rivalutato dalla Volkswagen!), all’impatto ecologico delle produzioni, in una fase in cui tutta la ricerca investe in quella direzione e si parla di mobilità sostenibile addirittura come alternativa all’auto individuale? A questo proposito, quale è il senso della messa in produzione a Torino della Jeep e della Panda, due modelli che probabilmente Obama per primo non desidererebbe si producano a Detroit in quanto di nessun significato nel quadro del rilancio di modelli che vengano in qualche modo ascritti alla “green economy”? E deve far riflettere un sintomo che la stampa economica ha enfatizzato, ma che richiama le bolle esplose dal 2009 in poi: il boom della quotazione del titolo Fiat dopo lo sdoppiamento alla borsa di Milano ha accompagnato un vero e proprio crollo dei risultati commerciali del gruppo, facendo impennare le stock options del manager, ma rimandando la sensazione di una base produttiva largamente insufficiente ed in cerca di ricollocazione. Siamo, in definitiva, all’assoluta mancanza di indizi tra una Fiat “stand alone”, sempre meno protetta da un governo italiano sempre più pove ro, e un’altra Fiat che, nell’auto, cer ca alleanze ed economie di scala con case estere fallite e resuscitate dai soldi di altri governi. Mentre, per un risanamento efficace va preso in considerazione l’aumentato del valore prodotto per ora lavorata, con un rilancio della progettazione, andan do oltre il mero scambio di compo nenti e marchi. Ma qui si tratterebbe di politica industriale, non di finanza…e chissà se “l’uomo col maglione” ne vuole e ne sa parlare.
6. Tutto fa pensare che sia l’intera società a rimetterci, se Marchionne vuole privare i lavoratori di un ruolo partecipativo-conflittuale e relegarli a terminali di decisioni in assoluta continuità con le scelte che hanno provocato la crisi in cui ci dibattiamo. Cambierebbe natura anche il sindacato e la CGIL in particolare, perché la rinuncia alle elezioni dei rappresentanti lo priverebbe della conoscenza diretta dei processi che può venire solo da uno scambio continuo con i delegati in produzione e interromperebbe quella relazione fra il sindacato-istituzione e il sindacato organizzatore diretto delle lotte che è stata la grande innovazione democratica iniziata a partire dal ’69. Lotte indispensabili per chi ha a cuore l’avvenire industriale del Paese e, contemporaneamente, l’avvio di una riconversione che assicuri occupazione buona e rigenerazione delle risorse del territorio in cui viviamo. Francamente non capisco perché, in una fase così facilmente decifrabile, la CGIL, dando spazio alla mistificazione che sta a cuore a Confindustria per uscire dall’impasse in cui si trova, si perda sui giornali in affermazioni sul massimalismo di una sua componente o sull’estremismo di Marchionne. Come se il disegno in atto sparisse d’incanto e ci fosse una terza via che dipende tutta dalla maggiore o minore ragionevolezza dei leader delle parti sociali (Camusso o Landini, Marcegaglia o Marchionne). Credo che anche sindacalmente il problema non sia affatto di isolare i metalmeccanici della CGIL, ma di riconquistare attorno ad essi l’intero mondo del lavoro, portato alla spaccatura dai comportamenti di Cisl e Uil. Gli appelli, le adesioni alla giornata del 28, l’allarme che si è creato anche nella parte più consapevole dell’opinione pubblica, la reazione difficilissima, repressa ma non rassegnata, dei lavoratori di Pomigliano e di Torino, lasciano aperta o comunque da riaprire la partita. Che lo si faccia unitariamente dipende dalla lungimiranza di tutte le componenti in gioco: noi dobbiamo lavorare per questo.


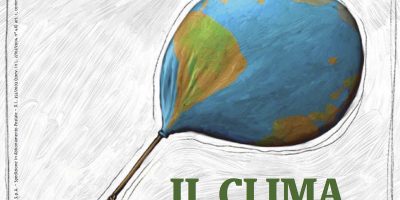
 Mario Agostinelli, sposato con due figli e cinque nipoti, è oggi presidente dell’
Mario Agostinelli, sposato con due figli e cinque nipoti, è oggi presidente dell’