Leggo meno i giornali e sempre più spesso mi infastidisce la televisione. Di conseguenza, la notizia della morte di Ermanno Olmi non mi è giunta “online nè metabolizzata da Wikipedia, ma attraverso il dolore già rimuginato da amici, il rincrescimento per un vuoto che non si può riempire a parole, l’apprezzamento sofferente per l’autenticità e la creatività di un uomo che sceglieva i tempi lunghi, sapeva collocarsi nella storia con le sue contraddizioni e riusciva a scrollarsi di dosso la rincorsa affannata del presente.
Come dice Tonio Dell’Olio, “non è moneta corrente che la storia contempli l’azione di registi ispirati e inventivamente geniali che hanno dato la parola agli ultimi”. E nemmeno che esalti quelli che hanno trasformato in poesia il dolore e la quotidianità senza cedere un frammento alla retorica né un granello alla verità nuda di storie solo apparentemente anonime e minori. Poveri, dialetto, terra e lavoro e poi qualche volo poetico e maestoso oltre le nostre pianure nebbiose – anch’io sono nato a Treviglio – per sognare la pace dopo la crudeltà delle guerre: un auspicio che viene sempre più rimosso, come se la pace non fosse il diritto da cui emanano e traggono senso tutti gli altri.
Il timore è che con lui se ne vada un mondo e anche un modo di interpretarlo. Provo una certa vena di pessimismo e non credo ai prodigi. Così, dietro la morte di Ermanno, vedo con rammarico una solidarietà infranta, tanti frammenti separati, ognuno dotato di ostinazione, poca sensibilità al pluralismo, perdita di meraviglia di fronte al vivente, che, anche quando muore, può invece trasferire la sua identità, la sua unicità in una eredità comune e incancellabile, se la si è potuta e voluta valorizzare a suo tempo nelle forme più aperte di comunità. Tocca ai giovani, ai loro slanci, alla loro fiducia, far sì che il mondo preso in prestito sopravviva anche grazie agli sforzi ancora in atto, sempre più persi e isolati in un assordante rumore. Ma, ripeto, non sono ottimista.



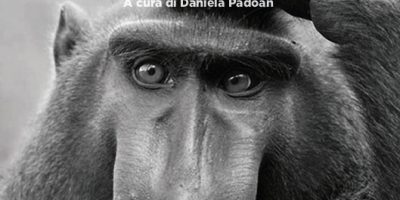

 Mario Agostinelli, sposato con due figli e cinque nipoti, è oggi presidente dell’
Mario Agostinelli, sposato con due figli e cinque nipoti, è oggi presidente dell’